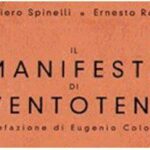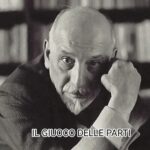Il racconto della Domenica: ” Rucola e…”
di Giuseppe Moesch*
In questo periodo dell’anno riprendeva la massiccia presenza di venditori ambulanti provenienti dall’immediato entroterra napoletano; i vicoli vicino casa si riempivano di donne ed uomini carichi di grosse ceste colme delle primizie degli orti, ovvero delle “parule”, che da sempre rappresentavano la ricchezza della campagna di quella che era un tempo definita come Campania Felix.
‘O parulare citato anche in molte classiche e più recenti canzoni, ricordiamo tra tutte Tammurriata nera, vestito con abiti da festa proponeva le sue mercanzie in particolare la domenica, quando i negozi tradizionali erano chiusi.
Andavo con mia nonna, talvolta con mia madre, quando in alternanza non erano dedite alla preparazione del ragù, funzione liturgica che riempiva la mattina della domenica, in direzione di via Cavallerizza, dove eravamo certi di trovare quegli ambulanti.
L’uscita era preceduta da un chiacchierare sommesso in casa, quando si davano indicazioni precise su cosa comprare e la richiesta era sempre la stessa: “Vedi se trovi” e poi un sussurrare incomprensibile per me ragazzino di pochi anni.
Non capivo le parole e venivo liquidato sbrigativamente con: “L’insalata, ho detto l’insalata”.
Solo da più grande ho capito il perché di quella reticenza; la richiesta era da intendersi per rucola e pucchiacchella.
A casa mia era assolutamente vietato parlare in napoletano. I miei nonni materni parlavano in dialetto tra di loro, per cui lo capivo perfettamente, ma ogni tentativo di usare quella lingua mi era interdetto secondo un modo di vedere tipico di molte famiglie borghesi, a maggior ragione era tabù ogni “malaparola” che sarebbe apparso come un sintomo di cattiva educazione. La parola pucchiacchella era troppo chiaramente associata alla analoga definizione dell’omonima zona femminile per poter essere compresa e ripetuta dalla creatura.
Non sono certo che all’epoca fosse nota la parola portulaca ovvero la designazione scientificamente corretta di quella pianta che nasceva spontanea nei campi e nei giardini, e si diceva che fosse raccolta da quegli ambulanti ai margini dei cimiteri; probabilmente perché, essendo zone poco frequentate, cresceva più rigogliosa; credo che questa diceria derivasse dal senso di peccato che la sua versione dialettale faceva intendere.
Sembrerebbe che il nome possa derivare dalla storpiatura dell’originale portulaca oppure riferirsi al portamento basso e coprente che per affinità era associata alla innominabile area femminile.
Il dolce sapore di quell’erba si mescolava nell’insalata che accompagnava la carne al ragù, a quello piccante e croccante della rucola in quel misto di sapori che piaceva a tutti i commensali. Puliva la bocca, condita appena con un filo d’olio, sale e talvolta con qualche goccia di aceto.
La mano stretta in quella sicura di chi mi portava con sé, uscivamo di casa in un’aria di festa primaverile, con il primo sole caldo, e la dismissione del cappottino che mi costringeva nei mesi precedenti e che mi infastidiva impedendomi i movimenti.
Imboccata la via Alabardieri che da Piazza de’ Martiri conduce all’incrocio con via Bisignano dove solitamente si fermavano gli ambulanti e dove cominciava la normale contrattazione.
Il contadino già all’avvicinarsi del potenziale cliente afferrava un foglio di giornale che avvolgeva intorno alla mano a formare il “cuoppo” che avrebbe contenuto la verdura. Iniziava la trattativa con la solita frase: “Ma è fresca?” frase retorica perché riferita ad una massa brillante e bellissima da vedere. Poi si passava al prezzo, che non poteva mai essere quello enunciato in prima battuta: “Signò, voi siete cliente” e mia madre o mia nonna: “Lo sapete io vengo sempre da voi”. Il voi era il modo normale di interloquire: in modo deferenziale da parte dei contadini che mantenevano uno stato mentale di subordinazione nei confronti dei “Signori” e da parte di questi derivante dall’abitudine ottocentesco di parlare alla “Servitù” in generale.
La trattativa andava avanti per un po’ intercalata da domande sullo stato di salute della famiglia e da espressioni del tipo: “’A creatura è cresciuta” e “Mo’ quant’anne tene?” intanto il cuoppo veniva riempito all’inverosimile mentre appariva d’incanto una stadera, che abilmente manovrata facendo scorrere il peso lungo l’asta, raggiungeva una posizione di apparente equilibrio, con la dichiarazione unilaterale del valore e l’aggiunta della frase magica: “Buon peso” che serviva a chiudere la trattativa nella certezza di tutti che il peso era fasullo, che l’importo era maggiorato rispetto al pattuito, ma con la soddisfazione dei contraenti per la compravendita completata.
Talvolta ci fermavamo a comprare un mazzetto di fiori di campo che un’altra donna offriva di fianco: già allora i commercianti avevano intuito la convenienza degli shopping center che sarebbero giunti dall’America solo una ventina di anni dopo.
Il ritorno a casa mi vedeva orgoglioso stringere nell’altra mano quei fiori che avrei offerto all’altra donna rimasta a preparare il pranzo mentre aprendo la porta venivo avvolto dall’odore del ragù che finiva di “pappuliare” sul fuoco.
*già Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno