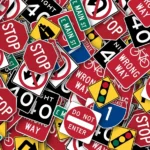Perizia senza periti, quando i giudici diventano “giudici-medici”
“PERIZIA SENZA PERITI”. Nel gennaio del 2020 in Arizona Rachel Henry, 22 anni, veniva imputata con una accusa gravissima di triplice omicidio per avere assassinato la figlioletta di appena sette mesi e di avere fatto lo stesso ad un altro suo bimbo di tre e ad un’altra piccina di due.
Secondo l’accusa, la Henry avrebbe portato il figlioletto più grande in camera da letto, cantandogli una cantilena. Mentre canticchiava, ha soffocato pure lui. Poi ha allattato la bimba più piccola di sette mesi e ha finito quest’ultima allo stesso modo, così come l’altra bambina di due anni. La donna ha quindi disposto tutti loro a letto come se stessero dormendo. I bimbi erano tutti morti.
Giova evidenziare che negli Stati Uniti è contemplata anche la pena di morte per i casi di infanticidio su minori di sei anni. E nel caso citato si tratta di un triplice omicidio di tale genere, aggravato da crudeltà e dalla parentela stessa tra vittime e carnefice. In Italia, lo scorso aprile 2021, si è verificato un fatto analogo, questa volta al contrario.
A cantare un canzoncina non era il carnefice, ma la vittima. In provincia di Monza, il giovane Davide Garzia ha ucciso la madre a calci e pugni “perché cantava”. Il ragazzo è stato quindi arrestato con le accuse di omicidio aggravato e vilipendio di cadavere dopo aver massacrato la madre Fabiola Colnaghi, 58 anni, infierendo poi sul cadavere. Il giovane ha spiegato al PM di essere stato colto da un “momento di sconforto”, dovuto alla depressione di cui soffriva, e al fastidio perché sentiva la madre cantare allegramente. “Ero depresso, nervoso, ci pensavo da tempo, poi vedendo l’allegria di mia madre tranquilla che canticchiava, mi è partito il raptus”, ha confessato. Il matricida avrebbe fatto sbattere la madre contro un armadio e poi, una volta che lei era a terra, l’avrebbe percossa fino alla morte con calci e pugni al volto, facendole sbattere il capo ripetutamente sul pavimento.
La donna era ormai esanime a terra quando lui le ha tagliato tutti i capelli e le ha rovesciato sul viso della candeggina. Solo a quel punto ha chiamato il 112. Stando ai primi accertamenti, tra i due le liti erano costanti. Davide Garzia è stato oggi riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto e quindi non imputabile, a seguito di una perizia psichiatrica. Mi sovviene una riflessione di Eduardo sul fatto che se dovessimo mettere in manicomio tutta la gente che non ragiona probabilmente non circolerebbe più nessuno.
Ancora più lapidario uno scrittore inglese definiva “pazzo” non chi ha perso la ragione, ma chi ha perso tutto fuorchè la ragione. Indubbiamente sono tanti i dubbi che sorgono nel comune cittadino di fronte ad episodi efferati e di inaudita ferocia, partoriti dalla mente di un essere umano che magari, qualche minuto dopo l’esplosione della insensata violenza, prende il telefono in mano, allerta i soccorsi oppure continua nelle proprie abituali faccende quotidiane, dimenticando o rimuovendo le atrocità commesse.
La cronaca giudiziaria è piena di casi di omicidio dove il confine tra la lucida follia e l’infermità di mente è veramente molto sottile. Secondo il nostro codice penale, non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
Non vi è chi non veda come la formulazione normativa sia molto generica, in quanto si tratta di definire in concreto che natura debba avere questa infermità per poter totalmente escludere la responsabilità del soggetto e la sua capacità di discernimento. Secondo l’elaborazione giurisprudenziale, l’alterazione della mente deve essere tale da incidere concretamente sulla capacità del soggetto, non deve consistere in una anomalia che riguarda solo la sfera della personalità o il carattere dell’autore del crimine.
Certamente non è contemplata la cosiddetta pazzia morale, ovvero l’assoluta mancanza di moralità dovuta a ragioni costituzionali del soggetto, non patologiche. Altrimenti, ogni criminale potrebbe giovarsi dell’esimente della pazzia. Bisogna, in ogni caso, accertare caso per caso se vi sia stato un effettivo stato di lucidità, ancorché transitorio, tale da poter escludere un vizio di mente, quale causa esclusiva del delitto commesso.
Ma alla fine, quando inizia il processo, come si scioglie il dubbio se ci si trova di fronte ad un criminale senza scrupoli o ad un povero pazzo? Chi sono quindi gli esperti della follia? Quali regole vengono stabilite per determinare lo stato mentale degli imputati? Quali sono i procedimenti attraverso cui viene di fatto affrontata la questione in sede giudiziaria? il sapere riguardante la follia (o, secondo la definizione della legge italiana, riguardante l’infermità mentale) che determina la condanna o l’assoluzione di un imputato per un delitto accertato fuoriesce immancabilmente dal quadro normativo che regola la produzione scientifica degli enunciati della psichiatria.
In effetti troviamo solo raramente periti psichiatrici, ovvero medici legali, che si pronuncino su tale questione, la quale viene affrontata dai vari attori della scena giudiziaria in forme diverse: osservazione scientifica, consultazione, parere, testimonianza, arringa, requisitoria. Nella prassi, quindi, non è il valore scientifico di tali pronunciamenti a determinare il verdetto finale, bensì la fiducia che gli attori ispirano nei giudici e, allo stesso tempo, il ruolo e il peso che tali argomenti rivestono nelle varie fasi del processo, l’uso che ne viene fatto dai giudici, dai pubblici ministeri o dagli avvocati.
Si può così concludere che il sapere competente in materia di follia può presentare vari volti e figure: psichiatri o medici legali, ma anche medici condotti, medici penitenziari, preti, sindaci, o individui comuni. Oltre a tali aspetti è importante sottolineare l’importanza dei giudici e del loro potere nella produzione del sapere dell’esperto.
Come mostrano i fascicoli giudiziari, sono proprio i magistrati a decidere se e quando convocare i periti o altre figure affinché pronuncino il loro parere sullo stato mentale degli accusati, sono loro a decidere se porre ai consulenti le domande relative all’infermità mentale, a prescindere dalle risultanze ottenute nei processi. È infine competenza dei giudici qualsiasi giudizio in merito: sono i giudici, in ultima istanza, i veri esperti della follia.
Questi giudici-medici, come li chiamerà Michel Foucault, non solo possono determinare la patologizzazione del crimine ma mostrano anche sino a che punto il diritto di punire possa arrivare a formulare giudizi sulla condotta e sul personale vissuto dei soggetti. In molti casi, avviene un’esplicita esclusione dei periti dalla scena processuale: è innegabile l’impressione di assistere a una netta affermazione dell’arbitrario, incarnato qui dall’onnipotente figura del giudice, a discapito degli altri saperi ausiliari della giustizia.