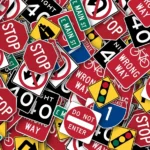Diritto e progresso
di Michele Bartolo-
Siamo abituati ad identificare il progresso in base alla sua definizione letterale, così come può trovarsi in qualsiasi dizionario della lingua italiana.
Si tratta, cioè, di “un avanzamento o trasformazione graduale contrassegnati da un sempre maggiore aumento di capacità e potenzialità ovvero dell’acquisizione da parte dell’umanità di forme di vita migliori e più complesse, in quanto associate all’ampliamento del sapere, delle libertà politiche e civili, del benessere economico e delle conoscenze tecniche”.
Allo stesso modo, sempre consultando il dizionario, sappiamo che il diritto è “un insieme ordinato di norme, variabili da tempo a tempo e da popolo a popolo, che prescrivono o vietano determinate azioni e comportamenti; queste norme hanno lo scopo di regolare i rapporti fondamentali (familiari, economici, politici) su cui si regge la società”. Se ne deduce, quindi, per uscire dalla definizione meramente letterale, che il progresso è un qualcosa in divenire, che si arricchisce di ciò che prima non c’era e ora c’è, mentre il diritto è antico quanto il tempo, in quanto la necessità di regolare la convivenza sociale nasce nel momento stesso in cui nasce la società, fosse anche composta da due sole persone.
Premesse queste considerazioni, come si evolvono e come si relazionano diritto e progresso nell’anno del Signore 2024, quasi 2025, per parafrasare un film di Benigni e Troisi?
Il pensiero non può non andare alla crescente digitalizzazione dei mezzi di cui il diritto si serve ed alla generalizzata telematizzazione del processo civile e penale. Il processo telematico, almeno nell’ambito del diritto civile, non è una novità degli ultimi mesi, nasce già nel 2015 e, dopo le iniziali resistenze, si è sempre implementato e ha di fatto sostituito la conservazione cartacea dei fascicoli processuali con indiscutibili benefici.
Con l’arrivo della pandemia da Covid 19, poi, il nascente processo telematico si è di fatto istituzionalizzato, diventando insostituibile nel periodo dell’emergenza, ma poi diffusosi in maniera capillare non solo per il deposito degli atti introduttivi ed endoprocessuali, ma anche per la stessa celebrazione delle udienze.
Nel periodo pandemico, infatti, con le varie chiusure e zone a colori, noi tutti sappiamo che il contatto fisico e le relazioni sociali erano quasi vietate, se non nella ristretta cerchia del proprio nucleo familiare. In quel contesto, l’aiuto fornito dal progresso tecnologico e dalla digitalizzazione si è rivelato fondamentale, consentendo appunto un generale ricorso allo strumento alternativo della videoudienza o dello scambio di note telematiche rispetto alla comparizione fisica delle parti e dei loro difensori.
Oggi, dicevamo, nonostante l’emergenza sia di fatto finita, è stato introdotto un articolo, il 127 ter del codice di procedura civile, che normativizza quanto accaduto nel periodo eccezionale: per una udienza di un processo civile la regola diventa la celebrazione in via telematica, neanche con la comparizione dei difensori mediante collegamento da remoto, ma realizzata mediante il semplice scambio degli scritti difensivi in una data antecedente alla udienza fissata dal Giudice, che rimane quindi meramente virtuale. Il giorno dell’udienza, infatti, il magistrato è solo nella sua stanza e, dopo aver letto in solitudine le note redatte dai difensori, che magari, per una diversa ricezione delle buste telematiche, non hanno avuto modo di leggere le difese della rispettiva controparte, emette il suo provvedimento.
La comparizione in presenza viene riservata a casi sporadici ed eccezionali, sostanzialmente quando sia necessario ascoltare persone diverse dalle parti e dai loro difensori, come nel caso dei testimoni. Lo stesso consulente tecnico nominato dal Giudice, pur essendo un terzo, può giurare in via telematica e fuori udienza. Ma, si dirà, lo stesso articolo consente che le parti possano opporsi all’udienza telematica e chiedere la fissazione di udienza in presenza, allorquando le richieste avanzate o le eccezioni sollevate richiedano una esposizione orale e comunque una interlocuzione immediata e diretta. Tuttavia, dal momento che la digitalizzazione ha ormai permeato l’intero processo, ove accada che, per una richiesta del difensore, il processo venga celebrato in presenza, il Giudice si dimostrerà quasi infastidito dal confronto verbale tra gli avvocati, tanto da richiamarli ad una estrema sintesi che, in ultima analisi, significherà richiamarsi integralmente a quanto già scritto, con buona pace del contraddittorio e del giusto processo.
Ecco è questo il problema fondamentale nel rapporto tra progresso e diritto: la tecnologia è un valore aggiunto, ma va comunque governata e gestita dagli esseri umani e, nel caso specifico, dagli operatori del diritto, se non si vuole essere sopraffatti da essa, consentendole di annullare il sistema di diritti e garanzie del nostro ordinamento giuridico, che appunto sono antichi come il tempo.
In buona sostanza, avanzare e progredire verso forme di vita migliori non può significare buttar via quanto di buono si è costruito prima, rinunciando alle stesse relazioni umani e sociali che costituiscono il fondamento di uno Stato civile e democratico.