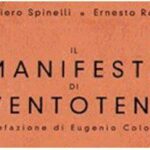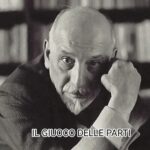La Famiglia
Sergio, Mariella e Luciana sono i tre figli di Mario, un ristoratore abruzzese, se non ricordo male, che insieme con i fratelli aprì a Roma un ristorante specializzato in pesce.
Anticipando di molti decenni una formula fortunata che avrebbe trovato molti estimatori da un lato ed imitatori dall’altro, offrivano negli anni ottanta una gamma di prodotti non molto usati nella ristorazione romana come lo era il pesce, con una proposta intelligente, non che non ci fossero luoghi dove era possibile mangiare prodotti ittici, ma erano luoghi di alta gamma, con prezzi esorbitanti, derivanti dalla deperibilità dei prodotti, e dall’assenza di alternative.
Il nome del locale alludeva espressamente all’eccellente sodalizio che esisteva tra i tre, e chi entrava aveva la possibilità di gustare una varietà di antipasti, diversi assaggini di primi e un misto di pesci e crostacei, seguiti da un sorbetto al limone ed eventualmente dolci o meglio tarallucci al vino, accompagnati da un buon vino della casa, ad un prezzo modico, alla portata delle tasche degli avventori, per lo più gente del quartiere, operai, artigiani, giovani professionisti che potevano godere di quelle prelibatezze senza dover sostenere una spesa eccessiva e forse proibitiva per le loro tasche.
Il trucco era nella formula del cibo uguale per tutti: variato, gustoso e abbondante ma servito in modo tale da far pensare all’attuale concetto del “All you can eat” e nello stesso tempo tale da non creare rimanenze e scarti che avrebbero fatto crescere i prezzi, di fatto industrializzando il processo produttivo.
 Si poteva anche ordinare alla carta, ma ovviamente il costo cresceva leggermente, sebbene nella maggior parte dei casi i clienti preferivano la formula che di fatto era a prezzo fisso. Non era ancora entrato in vigore l’obbligo dell’abbattimento e si scialava con il crudo ed era una festa quando arrivavano oltre alle solite ostriche, anche vassoi carichi di fasolari, vongole, tartufi, cozze, scampi, gamberoni, mazzancolle e carpacci di dentice o spigole a seconda della giornata, i gratinati come le capesante e i cannolicchi, annaffiate dal vino bianco gelato; mentre a completare la goduria arrivava prima della frutta e del dolce, per chi ce la faceva, il cosiddetto cazzimperio, ovvero il pinzimonio con le verdure croccanti di stagione da intingere nell’olio condito con sale e pepe.
Si poteva anche ordinare alla carta, ma ovviamente il costo cresceva leggermente, sebbene nella maggior parte dei casi i clienti preferivano la formula che di fatto era a prezzo fisso. Non era ancora entrato in vigore l’obbligo dell’abbattimento e si scialava con il crudo ed era una festa quando arrivavano oltre alle solite ostriche, anche vassoi carichi di fasolari, vongole, tartufi, cozze, scampi, gamberoni, mazzancolle e carpacci di dentice o spigole a seconda della giornata, i gratinati come le capesante e i cannolicchi, annaffiate dal vino bianco gelato; mentre a completare la goduria arrivava prima della frutta e del dolce, per chi ce la faceva, il cosiddetto cazzimperio, ovvero il pinzimonio con le verdure croccanti di stagione da intingere nell’olio condito con sale e pepe.
Il locale aveva il difetto di buona parte delle osterie romane ora come allora, ovvero era rumorosissimo, vi era un crescendo di suoni man mano che il vino faceva il suo lavoro, e che l’allegria ed il rilassamento dei freni inibitori, dava libero sfogo alle represse remore educative.
Quasi sempre passava uno o più gruppi di suonatori, e ne ricordo uno in particolare formato da due cantanti accompagnati dalle chitarre, che cantavano gli stornellacci romani, che tutti bantavamo in coro, tra i quali, in omaggio alle prime presenze di immigrati, o come si direbbe oggi, di extracomunitari, e giocando su assonanze leggermente volgari, vi era Ali-mo e Tacci-tù.
La fauna presente era assai variegata, sia nel mondo degli addetti ai lavori, per ognuno dei quali sarebbe interessante ricostruire il ricordo, ma sicuramente spiccavano tra di loro le due figure dei cuochi, due dei fratelli, di cui uno più piccolo e rotondetto, instancabile che saltellava tra le pentole che cuocevano sulla gigantesca cucina, novello Vulcano, con una maglietta della salute e la parannanza, sudato, gettava l’occhio dappertutto, pronto ad intervenire e attento a tutto ciò che accadeva intorno a lui, che si sentiva responsabile del successo del locale, attraverso il suo instancabile lavoro, e che nei rari momenti di tregua o alla fine delle sue creazioni usciva a salutare gli ospiti con un “A dottò, come va”, per sapere se il suo lavoro aveva avuto successo.
 La moglie, una donna dolce e mite, grande lavoratrice curava le preparazioni dei tavoli e produceva personalmente il sorbetto con maestria raramente vista, anch’essa attenta a che i camerieri fossero pronti e celeri a servire correttamente gli avventori.
La moglie, una donna dolce e mite, grande lavoratrice curava le preparazioni dei tavoli e produceva personalmente il sorbetto con maestria raramente vista, anch’essa attenta a che i camerieri fossero pronti e celeri a servire correttamente gli avventori.
Il terzo fratello, più alto e più magro, di indole e aspirazioni diverse dagli altri due, era assai più interessato ai risultati che alla componente esistenziale, saltellava dappertutto imprimendo velocità a tutto il lavoro nella speranza di liberare in fretta i tavoli per poter far entrare altri clienti che potessero far crescere l’incasso.
Un’altra figura interessante era quella di un cameriere di mezza età, che sembrava uscita da un film sulla malavita di mezza tacca romana; un uomo mite, ex pugile suonato, curvo nella posa difensiva dei pugili, che camminava con l’andatura leggermente ondulante di chi è abituato a muoversi sul ring saltellando.
Era spesso un problema trasmettere un ordine specialmente se multiplo, e spesso chiedeva l’intervento di un collega per essere certo di ciò che aveva inteso correttamente.
Nel locale lavoravano anche alcuni dei figli adolescenti dei titolari, che pur rispettando l’obbligo scolastico, contribuivano con il loro lavoro serale allo sviluppo economico della famiglia.
Molto variegato appariva anche il mix degli avventori ché oltre agli autoctoni, vedeva presenti professionisti ed intellettuali che apprezzavano sia la compagnia che principalmente la magnifica cucina.
Poi il colpo di grazia, quando il locale viene venduto e subentrano i cinesi, o forse chissà la malavita cinese, e la storia si interrompe. I tre fratelli si avviano ognuno per la propria strada. Quello più ambizioso entra in società con un altro addetto ai lavori, con il quale acquista un grosso ristorante fuori Roma, sulla via Ostiense, che dura poco.
L’altro fratello cuoco si allontana ancora prima ed apre un suo locale con la stessa formula precedente, ed un paio di anni dopo anche il terzo, Mario, decide di mettere su un nuovo ristorante, non più nella zona della Garbatella bensì a Monteverde sulla Gianicolense.
Oggi il locale non appare come il prodotto di uno stilista di grido, ed anzi affastellato di specchi o di orpelli vari, con alle pareti simboli di una cultura tradizionale con riferimenti alla fede cattolica, anche se in maniera ironica, con riferimento al nome del locale abbinato alle foto di papi.
 Quello che è rimasto della storia familiare, è la capacità che i giovani hanno saputo mostrare nel conservare lo spirito e la modalità di ospitare che anche dopo la scomparsa del titolare, hanno visto in Sergio il degno successore del padre, e la stessa coesione e capacità di lavorare insieme delle sorelle ed anche di Guido marito di Mariella, con la presenza in sala, anche se non costante dei loro figli che ripetono la trafila dei genitori.
Quello che è rimasto della storia familiare, è la capacità che i giovani hanno saputo mostrare nel conservare lo spirito e la modalità di ospitare che anche dopo la scomparsa del titolare, hanno visto in Sergio il degno successore del padre, e la stessa coesione e capacità di lavorare insieme delle sorelle ed anche di Guido marito di Mariella, con la presenza in sala, anche se non costante dei loro figli che ripetono la trafila dei genitori.
Ma perché interessarsi a questo gruppo di lavoratori, che non sono un esempio unico nel panorama della vita quotidiana di questo nostro Paese, che sembra stravolto dalle notizie di cronaca nera?
Siamo invasi da notizie di adolescenti fuori controllo che compiono delitti efferati, che secondo alcuni studi girano per oltre il 35 % armati di coltelli, non i coltellini svizzeri multiuso, ma vere e proprie armi da offesa. E che vengono spesso usati contro coetanei.
Non è un fenomeno localizzato nelle aree difficili del sud, Campania, Calabria, o Sicilia, ma presenti su tutto il territorio nazionale.
La risposta che ci sentiamo dare da soloni, nascosti sotto i curricula altisonanti di psicologi, psicoanalisti, assistenti sociali ed educatori vari è che la società dei social porta a queste aberrazioni, senza affrontare secondo me il tema centrale che è la formazioei di quelle giovani personalità confuse, che trova la sua base nella famiglia e nella capacità che genitori senza un certificato di abilitazione a quella funzione, non hanno offerto loro gli esempi sulla cui base costruire i valori necessari per quella formazione.
Il lassismo delle istituzioni, per dirlo più chiaramente della politica, ha permesso il rilassamento dei costumi e lo svilimento delle funzioni pedagogiche di base, a cominciare dall’accettazione di quanto avvenuto dal ’68 in poi.
Gli esami di gruppo, il 18 garantito hanno permesso di immettere nella società soggetti ignoranti forniti di laurea che il mondo dell’economia reale, non ha voluto e che sono andati a formare quei “disoccupaie intellettuali”, per i quali si sono aperte le strade del pubblico impiego, spesso nel campo dell’istruzione, portando in dote la loro ignoranza e la propria soluzione del non impegno personale e sociale.
Cosa potevano insegnare ai loro giovani discenti se non i mezzucci e le scorciatoie da loro adottati, quali valori avrebbero trasmesso ai loro figli se non la loro stessa presenza come modelli?
Gli anni successivi hanno, confermato l’andazzo, e dopo la sbornia pseudo rivoluzionaria degli anni ’70 e ’80, la deriva buonista ha completato il quadro e l’avvento dei nuovi operatori della scuola ha subito un ulteriore abbassamento, quando un lavoro prestigioso quale quello dell’insegnante ha visto la perdita di valore sociali, con stipendi sempre più miseri, la perdita di prestigio e di autorevolezza: quei sempre meno docenti preparati si sono visti prevaricati dall’ideologia e dalla invadenza di genitori attenti solo al successo espresso dal raggiungimento del pezzo di carta, e non dal livello qualitativo. Era quello l’obiettivo ed il fastidioso professore che poteva far rischiare il non raggiungimento del risultato, doveva essere bloccato ad ogni costo.
Queste considerazioni ci consentono di comprendere come il danno sia stato ormai compiuto, i comportamenti delle gran parte famiglie, dall’intolleranza alla mancata trasmissione di valori, è sotto gli occhi di tutti. I bambini che furono parcheggiati davanti alla TV, per permettere ai genitori di avere una propria vita di relazione o di godimenti da quattro soldi, sono diventati a loro volta genitori che alla TV hanno sostituito gli smart phone, novelle tate che permettono ancora maggiore libertà di seguire con gli stessi mezzi, tutti i social, che novelli guru ci indicano la via.
Non c’è da meravigliarsi se la cronaca quotidiana assomiglia sempre più ad un bollettino di guerra; ogni giorno un adolescente, ma ormai bambini di dodici o tredici anni, risolvono le loro piccole beghe tirando fuori il coltello che hanno con sé o portandolo da casa, con la consapevolezza sia che sia corretto risolvere così le dispute, sia con la consapevolezza che nulla potrà succedere loro in quanto minorenni.
Un’adolescente si impicca su pressione, bullismo, stalking del gruppo dopo una discussione sul possesso di un maschietto smidollato, un altro ragazzo viene ucciso con una pistola trovata per caso, da un amico fraterno membro di una famiglia con precedenti, Giulia Tramontano incinta di sette mesi viene uccisa da un Impagnatiello, con una marea di coltellate dal padre del bambino che già da prima aveva tentato di farla abortire somministrandole veleno per topi, mentre intratteneva relazioni con altre donne; Giulia Cecchettin uccisa da un Turetta, anche lei con una trentina di coltellate dal geloso fidanzato, narcisista, che non riusciva a tollerare i successi della donna che diceva di amare.
Non intendo elencare tutti i casi che ci hanno angosciato negli ultimi mesi, volendo solo sottolineare per tutti una serie di elementi comuni che possano farci comprendere cosa accade ed eventualmente vedere se sia o meno possibile trovare una qualche soluzione.
Mi ricollego allora a quanto ho descritto all’inizio di questa mia riflessione.
Anche la famiglia di Turetta è una sana famiglia che a dire di tutti non ha fatto mancare nulla al figlio, dalla macchina al benessere generale che gli ha permesso di studiare per raggiungere quella crescita sociale a cui i genitori ambivano, genitori ristoratori come Mario che abbiamo conosciuto più sopra.
Quale la differenza tra le due situazioni? Dalle dichiarazioni della famiglia Turetta, si evince l’assenza prolungata per il figlio a causa del lavoro, gli veniva chiesto di studiare e basta. Non di partecipare alla vita lavorativa dei genitori e quindi nessun rapporto esemplificativo dei sacrifici e delle motivazioni esistenziali, dell’altro gruppo.
I figli di Mario hanno visto il sudore del padre e gli occhi stanchi della madre, che è servito molto più di tante lezioni universitarie.
Filippo Turetta non ha potuto imparare niente dalla sua solitudine, dalla mancanza di una guida: aveva il danaro per crescere ma non il concime derivante dalla intensità di rapporti familiari, dalla dedizione che solo una famiglia in cui almeno uno dei componenti sia in parte presente, per offrire paletti, punti di riferimento rispetto ai quali orientarsi.
Un ragazzo o una ragazza piazzata su un divano con un telefonino che lo accudisce dandogli messaggi comportamentali, funzionali alla vendita di ogni tipo di prodotto, dal Pandoro alla correzione estetica, imparerà velocemente a credere che tutto sia ottenibile con un clic come lo scatto della molletta del coltello che porta in tasca, e che sia solo necessario il denaro per comprare la felicità effimera e momentanea delle vetrine reali o virtuali che ci vengono mostrate.
L’imitazione di quei modelli permetterà loro di sentirsi pari alle immagini che hanno visto; sono allenati e pronti già da dopo il primo decennio di vita ad inseguire ad ogni costo la soddisfazione dei propri egoistici desideri, esibendo in rete i propri successi effimeri e fasulli, pronti a seguire il primo pifferaio che gli fa credere di essere unici e diversi.
Se la famiglia non è più in grado di fare il proprio mestiere, non sarà certo la scuola che potrà sostituirla, perché la maggior parte dei docenti, specialmente quelli più giovani, sono assai simili a quei genitori distratti, ed, esclusi ovviamente alcuni meritevoli soggetti, la maggior parte appare immotivata e disponibile ad accettare che tutto continui nel flusso ormai inarrestabile.
Così tutti sanno che la scuola di fatto non comincerà veramente che dopo la settimana di occupazione, e qualche manifestazione di piazza con slogan ripetuti ossessivamente e valido per ogni stagione ed ogni contingenza.
Emblematiche le immagini mandate in onda nelle varie televisione che informavano i telespettatori delle manifestazioni che si stavano svolgendo in tutta Italia in occasione della ricorrenza del rigetto della violenza sulle donne. Una delle manifestazioni era rivolta a stigmatizzare la repressione delle libertà femminili in Iran, ricordando con foto la giovane che aveva osato sfidare le autorità della teocrazia levandosi gli abiti e restando n mutande, castigate mutande, e reggiseno.
Le stesse donne sfilavano poco più tardi a favore della Palestina, ignorando che Hamas, non solo è foraggiata dall’Iran, ma applica gli stessi principi religiosi, la stessa sharia, gli stessi burqa e gli stessi veli, contro i quali avevano poco prima protestato.
Chiedere che facciano pace con il loro tormentato cervello è certamente chiedere troppo, perché non sono sicuro che la famiglia e la scuola siano mai stati attenti rispetto a questa opzione.
L’assenza della politica ha permesso negli anni di lasciare che quelle masse di giovani restassero nell’ignoranza e crescessero nell’ottusità di slogan ad effetto, per mantenere saldamente il potere nelle mani di quei radical chic e appartenenti alle ZTL, che hanno potuto governare indisturbati.
Gli effetti di quel laissez faire si stanno facendo sentire pesantemente, e non basterà qualche provvedimento legislativo per risolvere i problemi.
I primi a dover essere rieducati sono i cittadini genitori che sono forse preoccupati quando toccano con mano quanto avviene ma non sono disposti ad accettare le proprie magagne: dovrebbero cambiare mentalità e stili di vita, ridurre il proprio spazio di egoismi e mettere in discussione tutto il loro percorso esistenziale.
Come avviene per un’auto per la quale si riscontrano difetti che possono minare la sicurezza dei passeggieri, e che le case produttrici richiamano in fabbrica per apportare le opportune modifiche, dovremmo fare lo stesso per le componenti difettose della nostra società.
Non credo che possa essere facile partire dalla famiglia, mentre credo che sia possibile richiamare in fabbrica i docenti per tentare di far loro comprendere la loro funzione, il loro dovere, le loro responsabilità, ridandogli quella dignità che taluni sembra abbiano perduto, accompagnando queste azioni con un ritorno rigoroso alle norme comportamentali basilari.
Il rispetto formale è alla base della vita di relazione, i nostri figli non sono nostri amici, ma figli; gli studenti non sono uguali ai docenti, sono esseri da formare, e devono essere consapevoli di ciò e comprendere che è nel loro interesse ed in quello della società nella quale saranno chiamati a vivere che la loro crescita va inserita.
Grazie Mario.
*già Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno