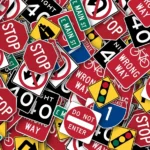Ramadante
di Michele Bartolo-
Solo qualche anno fa, nel 2021, si sono tenute le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri che hanno occupato le pagine di giornali e riviste nonché gli spazi televisivi e radiofonici, distanziandoci almeno per qualche tempo dalle paure, dalle preoccupazioni e dalle angosce della pandemia e ora della guerra.
Ora Dante torna nuovamente alla ribalta, ma non in senso positivo. Mi riferisco alla polemica nata in una scuola di Treviso dove degli studenti di fede islamica sono stati esonerati dalla lezione sulla Divina Commedia, in quanto Dante sarebbe offensivo nei confronti di Maometto.
Non è il primo caso e non sarà probabilmente l’ultimo in cui la civiltà cristiana, di cui siamo figli, deve cedere il passo o quasi mortificarsi della propria storia rispetto alla tradizione religiosa islamica, che non è certo universamente conosciuta come maestra dell’accoglienza. Sicuramente i doveri di un buon cristiano sono quelli di rispettare ed accogliere tradizioni ed usanze di popoli diversi, nell’ottica della pacifica coesistenza di religioni e culture distanti tra loro. Ma questo non significa e non può significare rinunciare alle proprie radici, alla propria cultura, alla propria identità. Sono tanti i precedenti di tale approccio, dall’atteggiamento verso la festività cristiana del Natale alla richiesta abolizione del crocifisso nelle scuole per arrivare alla guerra nei confronti del presepe, colpevole anch’esso di offendere la diversa sensibilità religiosa di alcuni.
Nel caso di specie, però, diamo a Dante quel che è di Dante, il nostro Sommo Poeta, il padre della nostra cultura ed il precursore della nostra storia moderna. Anzitutto, deve rilevarsi che l’influsso della cultura e del pensiero islamici sull’Occidente del Cristianesimo medievale è fuori discussione e, nella Commedia, la relazione fra il pensiero di Dante e quello dell’Islam si può configurare attraverso vari momenti. Innanzitutto, risulta particolarmente interessante la collocazione di Maometto e Alì agli inferi, tra gli eretici (canto XXVIII).
Ciò che fa riflettere e ragionare in questo contesto, rappresentato anche in San Petronio, a Bologna, da Giovanni da Modena (per il quale affresco si sono dovute attivare imponenti misure di vigilanza, a causa dei possibili attacchi dei fondamentalisti), è la collocazione del profeta islamico fra gli eretici (IX bolgia del VII cerchio, vv. 31-42). Ciò sta a significare che la cultura medievale, in cui il Poeta si innesta, considerava l’Islam come un prodotto del Cristianesimo.
Del resto, come sappiamo dalla storia, la figura di Maometto si staglia in un contesto “cristiano” (le tribù dell’Arabia del suo secolo), in cui prevale la concezione di Nestorio, secondo cui in Cristo alle due nature corrispondono due persone. Il profeta dell’Islam era ossessionato dall’idea dell’unicità di Dio, da preservare e custodire contro ogni idolatria. In nome di tale unicità negava a Gesù la natura divina, pur considerandolo un grande profeta e riservando a sua madre, la vergine Maria, un ruolo molto importante nel Corano. Ancora, resta stimolante la presenza fra gli “spiriti sommi” (Inferno, canto IV), di figure arabe quali Averroé, Avicenna e persino il Saladino, proprio colui che aveva sbaragliato eserciti crociati in Terrasanta e mozzato la testa a migliaia di Templari.
Le scelte che il Poeta mette in campo riguardo all’Islam suggeriscono una distinzione fra la religione e la cultura islamiche, sicché la prima, in quanto eresia del Cristianesimo, viene decisamente condannata, mentre alla valenza squisitamente filosofica, scientifica e culturale della fede musulmana si riserva un giudizio ben più benevolo, in quanto non si ignora il debito dell’Europa cristiana verso tali acquisizioni. Di ulteriore e significativo interesse è certamente il Libro della Scala di Maometto, a causa del suo influsso sull’escatologia della Commedia. Addirittura da qualche parte si è polemicamente sostenuto che l’escatologia dantesca e quindi la Commedia sarebbe una grande bufala, in quanto la struttura dell’aldilà e la vicenda stessa sarebbero “copiate” dai testi mistici dell’Islam, e quindi non avrebbero alcuna originalità. Indubbiamente vi sono analogie fra i contenuti dell’opera poetica e quelli degli scritti mistici islamici, anche se bisogna considerare che, a livello escatologico, come per esempio anche nella dottrina della creazione, la fede cristiana e quella islamica coincidono. Alcune fondamentali coincidenze fra Scala e Commedia sembrano inequivocabili: entrambi, Maometto e Dante, sono non solo i protagonisti, ma anche coloro che raccontano il viaggio ultraterreno. Entrambi hanno una guida o più guide Gabriele/Virgilio, moltitudine di Angeli/Beatrice e san Bernardo. Una differenza fondamentale consiste invece nel fatto che Maometto va prima in Paradiso e poi all’Inferno, Dante viceversa, passando per il Purgatorio.
La configurazione dell’Inferno, mediante la figura dell’imbuto, è comunque comune ai due testi, per non dire della serie delle punizioni. Luci e colori, suoni e musica sono invece gli elementi utilizzati da entrambe le opere per descrivere il paradiso, nonché l’organizzazione gerarchica degli angeli.
Ma, a parte la scrittura in prosa della Scala e quella in versi della Commedia, il punto focale è e resta il monoteismo, assoluto, quello islamico; trinitario quello di Dante. In questa prospettiva sarà forse da adottare nel rapporto con l’Islam il paradigma del confronto, che si è rivelato storicamente molto più fecondo e vivace dal punto di vista teologico e culturale. Ciò aiuterebbe la comprensione della realtà e delle differenze, con le quali dobbiamo imparare a convivere. Ci vengono in soccorso le parole dello scrittore Enrico Galiano che così si è espresso sul rapporto tra Dante e Maometto.
“Certo non si può negare che Dante abbia riservato parole poco gentili per Maometto, condannandolo all’Inferno tra i “seminatori di scandalo e di scisma”. Però, se ci fermiamo a questo dettaglio, rischiamo di perderci tutto il resto. Per esempio, sapevate che nel Limbo dantesco ci sono personaggi illustri della cultura islamica come Saladino, Avicenna e Averroè? Sì, proprio così. Dante li colloca tra i saggi dell’antichità, riconoscendo il loro valore e il loro contributo alla filosofia e alla scienza”. (..) Dante, con tutte le sue contraddizioni, non è solo un simbolo della cultura cristiana medioevale, ma anche un ponte verso altre tradizioni e culture”. Per tale motivo, “escludere gli studenti musulmani dallo studio della Commedia significa rinunciare a questa ricchezza, a questa possibilità di scoprire come le culture si influenzino a vicenda. Invece di vedere la Divina Commedia come un’opera divisiva o, peggio, come una specie di baluardo dell’italianità, possiamo considerarla un’opportunità per dialogare“. Secondo Galiano, dunque, “Dante ci mostra che, nonostante le differenze, ci sono punti di contatto tra mondi apparentemente lontani. Imparare a conoscere questi legami ci aiuta a comprendere meglio la nostra storia, il nostro presente e ad allargare la nostra visione del mondo, non a restringerla“. Ancora una volta la nostra tradizione cristiana è da preservare e si rivela utile anche per conoscere e comprendere meglio tradizioni, culture e religioni diverse e distanti dalla nostra.