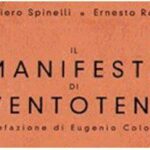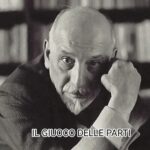Giorgio Gaber, filo rosso della mia vita
di Giuseppe Moesch*
Avevo 13 anni; ero pervaso di romanticismo, innamorato di Olga, mia compagna di classe che invece era innamorata del mio amico Peter, di uno o forse due anni più grande di noi, proveniente da Parigi, un mito per tutti.
Gli raccontai dei sentimenti di lei e si misero insieme, come si faceva all’epoca, piccoli baci e poco più. Mi sentivo un personaggio di quei vecchi romanzi che avevo divorato e quando ballando di pomeriggio a casa di Susy, altra nostra compagna di classe americana, la cui casa era disponibile per le nostre riunioni, vista la diversa mentalità della madre di lei, e prima del mio eroico gesto, cercavo Olga per un lento che mi permetteva di tenerla tra le braccia sulle note di “Non arrossire”.
Comincia così il mio lungo, lunghissimo rapporto con Giorgio Gaber, che non ho mai avuto la fortuna di incontrare personalmente e che è durato, ovviamente in modo unilaterale, fino al primo gennaio di vent’anni fa.
Nel febbraio del 1960 moriva Fred Buscaglione ed ho ancora vivo il ricordo della discussione avuta in classe con una delle due professoresse di materie letterarie, la più giovane, molto più prossima a noi come età, avrà avuto meno di trent’anni, rispetto alla sua collega che noi consideravamo vecchia, forse di poco maggiore dei quaranta. Fu cocente e quasi disperata la mia reazione alla sua indifferenza per il nostro dolore per la morte del cantante, le cui qualità canore la prof non apprezzava, così come non apprezzava i cosiddetti urlatori da Tony Dallara a Arturo Testa e Joe Sentieri, preferendo a quelli i Luciano Tajoli, i Claudio Villa, i Giorgio Consolini o le Wilma De Angelis peraltro grandi professionisti, e tollerando a mala pena la jazzista Flo Sandon’s.
Era un periodo in cui si andavano preparando le basi di grandi rivoluzioni in tutti i campi; il retro di “Non arrossire” era una canzone che forse oggi nessuno ricorda più, “Ninfetta”, apologia della voglia di affrancamento della donna che diventa sempre più indipendente, un pezzo rock scatenato cantato con lo stile con il quale Gaber si esibiva con i suoi amici: Celentano, con canzoni del tipo “Che dritta” o “Giarrettiera rossa”, oppure Jannacci, con il quale aveva inciso ”24 ore” ed “Ehi! Stella” e che l’anno successivo avrebbe scritto canzoni ironiche e satiriche come “L’ombrello di mio fratello” ed “Il cane con i capelli”, ed ancora Mina ai suoi primi successi, padrona di una voce meravigliosa che ancora non era stata sfruttata correttamente, tanto che al festival di Sanremo fu fatta partecipare con una canzone stupida e banale come “Non sei felice” in abbinamento a Betty Curtis.
Cosa c’era in quel gruppo di cantanti milanesi di così straordinario? Ritengo che la componente più singolare fosse la coscienza che il mondo del dopoguerra stava ancora in parte ripercorrendo stancamente i vecchi binari, che i ritmi provenienti dagli Stati Uniti cercavano di sostituire, mentre tutti gli stereotipi erano già defunti anche se ancora non era stato redatto il certificato di morte.
Già si poteva leggere nelle storie cantate da quel gruppo pioneristico la velenosa critica di quel mondo consumistico che si faceva strada con l’immagine di Celentano in “Che dritta” dove la ragazza in assenza della “giulietta”, “niente da far”, o ancora con “La maglietta” del 1964 dove Gaber descrive l’apprezzamento di una ragazza e delle sue amiche per un maschio insignificante che indossava una maglietta particolare, che diventa indifferente se privo di quel capo di vestiario, anticipando, con oltre cinquant’anni d’anticipo gli effetti delle varie Ferragni.
Gaber, insieme a Cochi e Renato, fa il coro nella canzone “Ho visto un re” cantata da Jannacci, su versi di Dario Fo, presentata per la prima volta nel 1966 e riproposta più volte fino all’ultima esibizione pubblica di Gaber in tv ospite di una serata di Celentano prima della sua morte. È interessante notare che la canzone era una irrisione al potere e lo si capì chiaramente quando la Rai impedì a Jannacci di presentarla alla finale di Canzonissima del 1968.
All’inizio degli anni settanta Gaber affronta un altro tema assolutamente scabroso, con la canzone “Oh madonnina dei dolori”, in cui il tema della miseria umana, non solamente di matrice economica, viene riproposto e connesso alla tragedia divina, concludendo con una frase “la mia e la tua, due famiglie rovinate” che ebbe per me allora lo stesso valore che avrebbe avuto in seguito quella sulla “Libertà come partecipazione”.
Il “signor G” o i “Polli da allevamento” e via via il passaggio sempre più deciso al teatro piuttosto che la televisione, sono state altrettante tappe della critica feroce in primis alla società che si stava trasformando, ma ovviamente alle false critiche da parte di greggi di giovani aizzate da chi agiva più o meno direttamente all’interno dello Stato, della Magistratura, della Scuola, che andava sempre più svilendosi nei contenuti e nei valori. I primi due mesi di scuola allora cominciarono ad essere dedicati all’occupazione ed ai cortei, moda che continua ancora oggi, sempre adducendo pretestuose ed inutili motivazioni, mentre nessuno prendeva l’iniziativa di intervenire per ridurre la deriva che avrebbe portato inesorabilmente alla triste condizione attuale.
È così che si arriva alla chiara ed univoca affermazione che non si possa accettare semplicemente la libertà come spazio libero senza regole – un moscone non è anarchico ma rispetta le proprie leggi – , la libertà non può essere raffigurata come distruzione di beni pubblici e privati, non significa ostentare striscioni con slogan scritti da uomini di marketing, ma è partecipazione, nel senso che è un impegno personale, di ciascuno a fare, per raggiungere quei valori espressi dalla costituzione. Gaber lo dice chiaramente che la destra fascista gli fa schifo ed altrettanto chiaramente dice: “e la sinistra?”
Non accettava l’idea che si potesse o dovesse partecipare perché tutti fanno così, secondo la moda del momento e ragionava con lo spirito critico verso quel partito che ha sempre dichiarato di aver votato.
L’elenco delle caratteristiche dell’essere di destra o di sinistra è sublime e le motivazioni sul perché si era comunisti sono una tristissima denuncia di un fallimento le cui responsabilità non potevano che essere attribuite ai dirigenti e responsabili di quel partito.
Uno degli ultimi passaggi fu espresso da Gaber nel disco “La mia generazione ha perso”, che nel corso delle mie lezioni di economia all’Università quando parlavo degli effetti della politica sull’economia, ho avuto modo di fare ascoltare ai miei studenti, con conseguente interessantissima discussione.
A metà degli anni ottanta, vinsi il concorso per associato ed ebbi la possibilità di scegliere tra l’Università di Torvergata o il Politecnico di Milano ed optai per quest’ultimo, sia per il prestigio dell’istituzione sia perché pensavo di poter vivere in quell’ambiente della loro Milano così ricco di quei fermenti: trovai la Milano da bere.
Con questi pensieri mi sono seduto a vedere il Documentario che la Rai ha offerto nel ventennale della morte di Gaber, anche se devo dire con una timorosa sensazione che l’operazione fosse stata organizzata per acquisire l’uomo all’eredità di una sinistra priva ormai priva di eroi spendibili.
Non si comprende il senso del contributo offerto da Fabio Fazio e Jovanotti. Ambedue sono privi di qualsiasi diretto collegamento con l’uomo Gaber o con il gruppo di appartenenza. Avessero intervistato la cameriera o il barista del Trani a gogo si sarebbe facilmente compreso il contributo del ricordo, se avessero chiesto al netturbino che di sera puliva le strade dei Navigli di quegli anni, avremmo potuto comprendere almeno il clima, l’aria che si respirava, ma ascoltare il pensiero di quei due invitati mi ha fatto pensare al Foscolo che in un famoso epigramma disse “Questi è Vincenzo Monti cavaliero, gran traduttor dei traduttor d’Omero”.
Ovviamente questa scelta ha comportato nella trasmissione il trasferimento dell’idea che Gaber fosse appartenuto allo stesso gruppo di quei due signori e quindi ecco il furto.
La seconda considerazione è stata sulla delegittimazione dell’uomo sul piano politico da parte di Bersani, che, pur apprezzando alcune delle cose che egli aveva espresso, ha tuttavia sentito la necessità di esprimere un giudizio critico sulla valutazione che Gaber aveva fatto su quel movimentismo di moda e sul fatto che fosse falsa la sconfitta di quella generazione, come se quello che abbiamo oggi sotto gli occhi fossero eventi che oggi si verificano in Uganda, solo per restare nella citazione delle sue canzoni.
Non meno facile appare la giustificazione senza commenti del pensiero del trapezista Capanna, che dopo tutte le evoluzioni della sua carriera politica ha voluto esprimere il suo lineare pensiero a danno di un grande artista e di un fine pensatore politico.
Il problema non è la valutazione fatta oggi da chi l’ha conosciuto ed ammirato nei suoi variegati aspetti, ma quello delle prossime generazioni, quando gli ultimi partecipanti di quei tempi così complessi non ci saranno più, ed esse avranno a disposizione un documentario ufficiale della Rai, ma di quella Rai 3 di cui Gaber ironizzava nelle sue storie.
E questo non mi sembra giusto
*già Professore Ordinario presso l’università degli Studi di Salerno
Foto. Unknown (Mondadori Publishers). Public domain