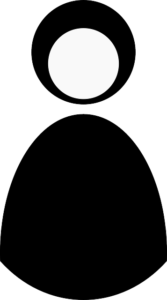In Francia sarà vietato indossare l’abaya a scuola. Tra laicità e libertà personale
Il ministro dell’Istruzione francese Gabriel Attal è stato categorico: “non sarà più possibile indossare l’abaya a scuola”.
L’abaya è un tradizionale vestito della cultura mediorientale, una lunga tunica che, solitamente, viene indossata su altri vestiti. L’equivalente maschile dell’abaya è il qamis.
In Francia – paese nel quale il concetto di laicità dello Stato è fortemente radicato da tre secoli a questa parte – discussioni di questo genere si ripropongono con cadenza periodica.
Nel 2004, il presidente Chirac volle fortemente la cosiddetta “legge sulla laicità” che vieta di “indossare simboli o indumenti che ostentino l’appartenenza religiosa”. Un po’ lo stesso concetto espresso da Attal in questi giorni, che ha detto che “non si dovrebbe essere in grado di identificare la religione degli studenti solo guardandoli”.
Quella contro l’abaya è una battaglia che ha già avuto un suo, importante precedente con il burkini, il discusso costume da bagno utilizzato dalle donne musulmane che consente loro di tenere scoperti piedi, mani e viso e interamente coperto tutto il resto del corpo. Nel corso degli anni, decisioni politiche e sentenze di legittimità costituzionale hanno affrontato il tema.
In particolare, dopo gli attentati dell’Isis a Parigi del 2015 (centotrenta morti), quello di Nizza del 2016, quando un uomo alla guida di un camion travolse e uccise ottantasei persone, e l’uccisione di un prete a Saint Etienne, molti amministratori comunali hanno deciso di vietare l’accesso alle spiagge cittadine alle donne col burkini, abbigliamento ritenuto non idoneo.
Una misura sensata o un mero atto di ribellione e, se vogliamo, di vendetta? Il dubbio resta, insinuandosi nella ormai datata disputa tra laicità dello Stato e libertà personale.
Ma non solo di quello si parla. Perché se è vero che il concetto di laicità è molto presente in Francia, in Italia ordine di paragone è quello di tradizione, di cultura prevalente, che significa essenzialmente rispetto della religione cattolica, che ha smesso di essere religione di Stato ma che, per molti, rimane irrinunciabile punto di riferimento.
Non si discute di lunghe tuniche e veli ma di crocifisso nelle classi. Anche questa è una battaglia – in un senso e nell’altro – che va avanti da anni.
Dunque, laicità, libertà personale, tradizione e cultura. Tutti elementi che appassionano, che dividono e che necessitano di essere compresi. L’obiettivo? Raggiungere un equilibrio, ancorché delicato, difficile e, forse, effimero.
La prima considerazione che si può fare è che sarebbe sbagliato, grandemente sbagliato, se decisioni di questo tipo venissero prese sulla base di un pregiudizio, su una volontà punitiva di condannare una cultura ritenuta diversa, lontana e, magari, incompatibile.
Non trovo il nesso tra burkini e attentati terroristici, non comprendo quale problema comporti indossare l’abaya o il qamis, purché questi abbigliamenti rendano possibile identificare ogni studente. L’equilibrio è fragile e proprio per questo motivo va raggiunto col minore spargimento di sangue possibile.
L’assimilazionismo francese – quell’approccio all’immigrazione secondo il quale ottieni la cittadinanza con facilità (rispetto all’Italia, per esempio) ma devi fare voto di fedeltà alla tua nuova patria, in pensieri, parole, opere e abbigliamento – sta manifestando, oggi più che mai, i suoi limiti. I golpe africani degli ultimi mesi hanno tutti un elemento comune: l’avversione nei confronti del vecchio colonizzatore transalpino.
Dunque, libertà personale, che va garantita nella forma più ampia possibile perché non viene riconosciuta ad una religione, ad una fede, ad un credo ma ad una persona. E se si intraprende il sentiero delle proibizioni ordinarie storicamente si sa da dove si parte ma non si sa dove si arriva.
Venendo all’Italia, in cui, come si è detto, il discorso è parzialmente diverso, mi chiedo il perché del crocifisso nelle classi. Lì non si discute di libertà personale ma di attribuire ad una istituzione pubblica una precisa connotazione religiosa. C’è una storia millenaria che ci lega alla Chiesa di Roma, certo; c’è una storia centenaria che lega la politica italiana all’importante contributo Vaticano, anche quello è vero, ma oggi, credo, faremmo maggiore servigio alla chiesa cattolica se la lasciassimo allo spazio privato di ognuno.
Diverso è il presepe a Natale: quello è, sì, un simbolo culturale. E accanto al presepe rappresentiamo tutte le altre culture, tutte le altre religioni. Dimostriamo che, per convivere, non servono leggi e prescrizioni ma solo buon senso.
Laicità e tradizione sono concetti importanti ma l’Occidente è tale se continua a riconoscere la primazia della libertà personale, che ha dei paletti, senza alcun dubbio, perché inizia dove termina quella degli altri, ma che, proprio per questo motivo, è fonte di garanzia per tutti.