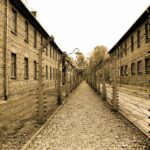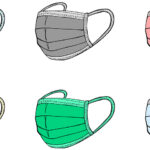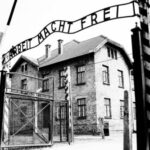Intervista alla dr.ssa Anna Manzo, dirigente medico Istituto Nazionale Pascale di Napoli
di Clelia Pistillo-
La pandemia da Covid 19 ha concentrato su di sé tutte le nostre attenzioni ormai da oltre un anno, mettendo a dura prova la resistenza del sistema sanitario e soprattutto di chi in maniera eroica ha affrontato in prima linea questo delicatissimo momento storico.
Ne parliamo con la dottoressa Anna Manzo, dirigente medico dell’ Oncologia clinica sperimentale toraco-polmonare, in servizio presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli.
L’emergenza da nuovo coronavirus ha indotto le strutture sanitarie ad una riorganizzazione nei percorsi di diagnosi, cura e assistenza. In che modo questo ha impattato sull’attività ambulatoriale , sulla continuità dei processi di cura e sul timing chirurgico?
Nella prima fase della pandemia molti pazienti hanno preferito evitare le strutture ospedaliere e nonostante noi non ci siamo fermati con ambulatori, ricoveri e terapie, alcuni pazienti, soprattutto in follow-up hanno rinviato i controlli ambulatoriali. Inoltre la paura di contrarre l’infezione ha determinato un ritardo nella diagnosi delle neoplasie perché le persone hanno ignorato i primi sintomi e sono arrivati in ambulatorio con quadri più avanzati. Per quanto riguarda invece i pazienti in terapia, quest’ultimi non hanno per nulla risentito della pandemia nel timing del trattamento, ma chiaramente la necessità di misure di controllo ((triage all’accettazione) e distanziamento si sono fatte sentire: a questi ammalati è mancato, infatti, il contatto fisico con i medici, anche la semplice stretta di mano, e ciò ha inciso moltissimo in termini psicologici.
Sappiamo quanto sia importante il rapporto che si viene a creare tra un paziente oncologico ed il clinico che lo assiste. Il covid ha imposto numerose restrizioni in tal senso. Come ha reagito il paziente e come si è riadattato al venir meno di questo contatto umano?
Il contraccolpo iniziale è stato importante, soprattutto per chi come noi è abituato ad un contatto fisico: siamo abituati a baci, abbracci, strette di mano. Anche per i nostri pazienti non poter ricevere un sorriso o una pacca sulla spalla è stato difficile da metabolizzare, soprattutto all’inizio. La comprensione però della necessità di portare avanti misure restrittive a tutela principalmente della loro salute ha consentito loro di accettare la nuova realtà delle cose e di riadattarsi a leggere il conforto anche negli occhi e non solo nei gesti.
Nelle fasi più acute dell’ emergenza si è avuta ovunque una riduzione degli screening e dei controlli e si è però notata anche una tendenza da parte dei pazienti stessi a rimandare le visite. C’è stata, secondo lei, una minore fiducia percepita nei confronti degli ambienti ospedalieri da parte dei pazienti? Che ripercussioni ci saranno in futuro?
Io penso che nella prima fase dell’epidemia la paura abbia giocato un ruolo importante nel rinviare le visite di controllo per molte persone. Credo che più che una minore fiducia negli ambienti ospedalieri, ci sia stata una paura diffusa di contrarre l’infezione anche solo uscendo di casa.
L’aver rinviato i controlli chiaramente potrebbe aver determinato un maggiore rischio di identificare più tardivamente una malattia o una ripresa di malattia per i pazienti in follow-up, ma devo anche dire che grazie alle misure di prevenzione messe in atto dalle strutture ospedaliere ed il diffondersi delle vaccinazioni, la maggior parte dei pazienti ha già ripreso i controlli regolarmente.
Il covid ha incentivato l’introduzione e l’utilizzo di nuovi strumenti comunicativi e di nuove forme di contatto. È stata implementata la telemedicina. Come funziona? Quali sono i pro e i contro? Come è stata accolta dai medici e dai pazienti?
Durante la pandemia abbiamo diviso i pazienti in 2 gruppi: quelli in trattamento attivo, per i quali rimava la necessità di visite in presenza, e quelli in follow-up liberi da malattia, che stanno bene e fanno solo controlli, per i quali i controlli sono stati riorganizzati attraverso le visite di telemedicina. In istituto infatti sono stati istituiti degli ambulatori di telemedicina che consentono una videocomunicazione tra medico e paziente ed evita il gap dell’assenza di contatto visivo a cui inizialmente avevamo rinunciato effettuando i controlli tramite invio mail dei referti degli esami strumentali. Con le televisite il medico vede il suo assistito, eventuali disturbi di nuova insorgenza, piuttosto che tossicità cutanee ad esempio legate a terapie biologiche per i pazienti polmonari e il paziente si sente più sereno nell’aver parlato vis a vis con il medico. Il limite della telemedicina sta chiaramente nell’impossibilità di effettuare un esame obiettivo, ma ci consente però di valutare quali pazienti necessitino maggiormente di un controllo in presenza.
Cosa consiglia a chi ha interrotto i controlli periodici oppure a chi vuole intraprendere i percorsi di screening?
Il consiglio è sicuramente di prenotare una visita e ricominciare gli screening, magari preferendo una televisita per chi preferisce ancora evitare le strutture ospedaliere.
Quest’ anno sono stati sospesi anche i congressi medici e quelle occasioni di incontro e crescita professionale che sono fondamentali per l’aggiornamento in medicina. I webinar hanno riempito il gap venutosi a creare? Crede che ci sia stato anche un rallentamento nel campo della ricerca sperimentale, sullo sviluppo dei nuovi farmaci?
I webinar sono stati una valida risposta alla necessità di aggiornamento dei medici in epoca di pandemia, soprattutto perché la ricerca oncologica non si è mai fermata. Abbiamo continuato a portare avanti gli studi clinici, arruolando pazienti e dando loro la possibilità di accedere a nuovi farmaci.
Quelli oncologici sono considerati pazienti fragili, vi sono controindicazioni assolute al vaccino? Tra essi ci sono sottogruppi che hanno la priorità? È indicata, ad esempio, la vaccinazione per gli immunocompromessi ?
Al momento in base ai dati attuali, è preferibile non somministrare il vaccino solo a pazienti con controindicazioni a uno specifico componente del tipo di vaccino proposto (analogamente alla popolazione generale). Sia ESMO che AIOM raccomandano la vaccinazione ai pazienti oncologici, in quanto dai dati raccolti fino a questo momento nella popolazione oncologica in trattamento attivo è emerso che questi ultimi presentano un aumentato rischio di mortalità dopo infezione da COVID-19. Pertanto, i pazienti oncologici in trattamento attivo devono ricevere la vaccinazione prioritaria SARS-CoV-2, se possibile la vaccinazione andrebbe effettuata prima dell’inizio della terapia oncologica. Nei pazienti che hanno già iniziato il trattamento, i dati esistenti non indicano una tempistica specifica di somministrazione. Tuttavia, rifacendoci all’esperienza maturata nella somministrazione dei vaccini antinfluenzali e antipneumococcici in pazienti in trattamento oncologico attivo, quali chemioterapia, immunoterapia, terapia biologica, radioterapia e trapianto di cellule staminali, si consiglia di vaccinare i pazienti in prossimità della somministrazione del trattamento oncologico, quando la conta leucocitaria è ottimale, evitando di vaccinare al nadir o in prossimità di esso, previo controllo dell’emocromo.
Nell’ anno della pandemia si è notato un proliferare delle fake news. In generale quale atteggiamento consiglia rispetto alle supposizioni inerenti gli effetti a breve, medio e lungo termine della vaccinazione, anche sostenute da nutriti gruppi di no vax?
Le fake news in ambito scientifico purtroppo sono sempre esistite ma la pandemia ha innescato un pericoloso stato di incertezza che ha spinto le persone alla ricerca spasmodica di informazioni non prestando attenzione alle fonti. Raccomando sempre di non sentire nel tranello del sentire dire e di riferirsi a siti istituzionali e accreditati per informarsi.
Da medico non posso che rassicurare tutti sul fatto che i vaccini siano sicuri, sono testati e vanno fatti per superare questa situazione pandemica.
Tutti i farmaci, anche quelli oncologici, dopo l’approvazione e la messa in commercio, vengono sottoposti ad un monitoraggio da parte di AIFA, tramite un registro, al fine di identificare eventuali eventi avversi rarissimi che si presentano solo quando il farmaco in questione viene assunto da moltissime persone (più di quelle che lo assumono durante le fasi della sperimentazione clinica). Questa fase di sperimentazione clinica, detta fase IV, ha appunto lo scopo di identificare gli effetti rari e a lungo termine dei farmaci.
Secondo una celebre massima la donna ha sempre dovuto portare due pesi, quello pubblico e quello privato. Da donna, lei come ha vissuto l’ impatto della pandemia sulla gestione del lavoro, della vita privata e degli affetti?
Chiaramente le donne hanno pagato il prezzo più alto della pandemia perché soprattutto le mamme lavoratrici hanno dovuto fare i salti mortali per riorganizzarsi non avendo il supporto della scuola, della baby-sitter, dei nonni. Io personalmente nei primi mesi della pandemia ero ancora in maternità, successivamente mi sono organizzata grazie allo smart working di mio marito, ma non nego che sia stato difficile riorganizzarsi senza supporti esterni al nucleo familiare stretto.
Cosa ci insegna questa esperienza? C’è qualcosa di positivo che potremmo trarre a nostro vantaggio per il futuro?
Ci ha insegnato probabilmente ad essere più essenziali. Abbiamo imparato l’importanza del gestire meglio il tempo, cerchiamo ad esempio di evitare ai pazienti e familiari spostamenti non necessari. Abbiamo cercato di sburocratizzare un po’ l’assistenza, rendendo più agevole per i pazienti l’accesso a modulistiche necessarie per ritirare i farmaci.
Inoltre senza dubbio, abbiamo riscoperto il valore dei sorrisi e più in generale del supporto psicologico per i nostri ammalati.