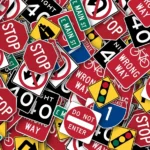Il “Caso Fortezza”: Strasburgo condanna l’Italia per aver calpestato e violato i diritti e la vita intima di una donna vittima di stupro
-di Michele Bartolo-
La Giustizia, come sappiamo, cerca di appurare la verità reale ma molto spesso la verità processuale non si identifica con ciò che è realmente accaduto. Si aggiunga, poi, che le sentenze, al di là del mero dato normativo, sono comunque il frutto di una applicazione della legge al caso concreto e quindi di un percorso motivazionale che il singolo giudice compie, nell’ambito dei margini di discrezionalità di cui dispone.
Nell’esaminare singoli casi giudiziari, abbiamo messo in luce l’alternarsi di pronunce contrastanti, a volte conflittuali, adottate sulla base dello stesso materiale probatorio e come tali sconcertanti, nella misura in cui hanno determinato un disorientamento nel comune cittadino, legittimando, nella migliore delle ipotesi, un senso di sfiducia nella macchina del processo e, in ultima analisi, nella Giustizia.
In ogni caso, deve evidenziarsi che il Diritto, per quanto debba consentire l’accertamento della verità, viene partorito dalla mente umana, che rimane fallace e soggetta all’errore. Uno stato di diritto, però, deve far prevalere sempre i diritti umani fondamentali e quindi dare anche all’errore la possibilità di emergere e di essere emendato nel corso del procedimento, allorquando sia stato la conseguenza di un ragionamento o di una motivazione viziata da una interpretazione errata o meramente personale ed emotiva di un fatto storico oggettivo. Il limite al potere discrezionale del magistrato, infatti, va in ogni caso ricercato non solo nel dato normativo ma nella corretta formazione della motivazione, che deve essere ancorata il più possibile a quanto emerso dal materiale probatorio ed alla oggettività della fattispecie concreta, senza alcun condizionamento emotivo, personale o, peggio ancora, esterno.
Questa lunga premessa ci aiuta a comprendere la portata della recente pronuncia della Corte Suprema dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che ha condannato l’Italia per aver calpestato e violato i diritti e la vita intima di una donna vittima di stupro, alla quale dovranno ora essere risarciti i danni morali per l’ingiustizia subita.
La sentenza si riferisce al caso Fortezza Da Basso, avvenuto nell’ estate del 2008. Tutto nasce con la denuncia sporta da una ragazza ventitreenne nei confronti di alcuni amici, accusati di una presunta violenza sessuale di gruppo, consumatasi nel parcheggio della Fortezza da Basso di Firenze dopo una festa.
In primo grado, gli imputati furono condannati a quattro anni e sei mesi di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti responsabili dell’accaduto. Nel marzo 2015, però, la Corte di Appello di Firenze, ribaltando completamente la sentenza di primo grado, pronunciava sentenza di assoluzione di tutti gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Giova ricordare che l’accusa aveva sostenuto che i giovani avessero fatto ubriacare la ragazza per poi approfittare del suo stato di menomata difesa, mentre la tesi avversa si fondava sull’assunto consenso al rapporto da parte della vittima.
Le motivazioni dell’assoluzione aprono un inquietante scenario sul ragionamento metagiuridico condotto dai giudici per pervenire all’esito assolutorio. E’ dato leggere, infatti, in alcuni passaggi della sentenza che la ragazza avrebbe voluto “rimuovere” quello che riteneva essere stato un suo “discutibile momento di debolezza e fragilità” in una “vita non lineare” e che “la ragazza aveva tenuto una condotta tale da far presupporre che, se anche non sobria, era tuttavia presente a se stessa”.
I giudici di secondo grado proseguono affermando che “i ragazzi possono avere male interpretato la disponibilità della giovane”.
L’intrusione nella vita intima e privata di una persona, quindi, diviene occasione per trasferire il giudizio dal piano etico a quello penale, ritenendo insussistente il reato nella ipotesi in cui la vittima abbia una vita non lineare ovvero, come nel caso di specie, perché bisessuale dichiarata, perché proveniente da una esperienza di convivenza, perché femminista ed attivista o perché adusa ad un abbigliamento provocatorio e non conformista.
Al di là del merito della vicenda processuale, ciò che emerge da questi passaggi della sentenza, giustamente censurati dalla Corte di Strasburgo, è la carenza motivazionale, comprovata dall’assenza di un grado di approfondimento della vicenda concreta, che fa comprendere come e quanto siano pericolosi ragionamenti semplicistici, basati sui luoghi comuni, che impediscono di valutare un fatto con profondità di pensiero, onestà intellettuale e ricerca della verità.
D’altronde la stessa tematica dello stupro e, nello specifico, dello stupro di gruppo, è quasi sempre caratterizzata da una demarcazione molto sottile tra il lecito e l’illecito, proprio perché spesso tra vittima ed autori del reato intercorre un rapporto di amicizia o, quanto meno, di conoscenza, che fa rimuovere l’idea comune che la violenza sia sempre il frutto di una aggressione brutale e clandestina.
Perciò la tematica del consenso, reale o presunto, riveste una importanza notevole, in quanto vanno indagati con attenzione gli elementi del caso concreto, portato all’attenzione della Giustizia, senza cedere a facili semplificazioni o a comode scorciatoie, quasi creando una scusante generale e pericolosamente generalizzabile.
Probabilmente una sentenza assolutoria che si basa sullo stile di vita della persona offesa va incontro ad una condivisione da parte dell’opinione pubblica dominante, che con semplicità ragiona e con semplicità giudica, come ci ricorda la famosa frase: “Se l’è andata a cercare”.
Ma la pronuncia della Corte di Strasburgo, che ha sottolineato come la sentenza definitiva sia stata influenzata da stereotipi sessisti e, in più, non ha tutelato i diritti della vittima che denunciò l’abuso, violando anche l’articolo 8) della convenzione europea sui diritti umani, che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ci induce a riflettere di nuovo sul ruolo dei giudici e sulle garanzie che il processo deve dare a ciascun cittadino.
Si badi bene, non è questione di morale, le opinioni e le convinzioni personali possono essere giuste o sbagliate, condivisibili o non condivisibili ma, comunque e sempre, sono legittime e lecite agli occhi del Diritto.
Quando il giudice si pronuncia, però, non può farlo sulla base della morale o di una opinione, ma deve farlo sulla base di un ragionamento che sia motivato ed argomentato, tale da poter essere unanimemente condiviso in ogni fase del processo.
Diceva il grande filosofo e psichiatra Carl Gustav Jung: “Pensare è difficile. Per questo la maggior parte della gente giudica”.