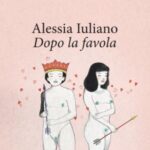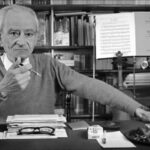No alla violenza sulle donne. Intervista all’avv Anna Santini
-di Denata Ndreca
Che cosa dobbiamo fare ancora per poter avere il diritto di dire di no ad un amore finito? Per poterci alzare una mattina e dire senza paura: questa non è più casa mia? Quanto ancora dobbiamo sopportare se la nostra anima e il nostro corpo ci indicano un’altra via?
Le pupille della nostra società continuano a vedere in parti disuguali l’uomo e la donna nei contenuti della quotidianità lavorativa e casalinga. Il confinamento dovuto alla pandemia, non è stato un aiuto per quanto riguarda le categorie vulnerabili e, tanto meno per le donne che subiscono violenza, perché a volte, è proprio dentro le quattro mura che si consumano le più grandi tragedie, nel silenzio più totale.
È di queste realtà che ne parliamo oggi, nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in un’intervista con l’avvocato Anna Santini.
-Che cos’è il femminicidio?
Il vocabolario Treccani riporta alla voce femminicidio la seguente definizione -uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica o annientamento morale della donna e del suo ruolo sociale-.
In termini più ampi si può estendere a qualsiasi -forma di violenza esercitata sulle donne (spesso in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale) allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne la soggettività sul piano psicologico, simbolico, economico e sociale, fino alla schiavitù o alla morte-“
In questa accezione il femminicidio non indica soltanto l’omicidio di una donna in determinati contesti e condizioni, ma anche il compimento di atti violenti reiterati nel tempo che non necessariamente provocano la morte.
-Quante sono le vittime nel 2020, fino ad oggi? Quanto ha inciso il Lockdown nella riduzione del numero di denunce avvenute in questo ultimo periodo di pandemia?
Se ci limitiamo alla vera e propria uccisone delle donne solo nei primi sei mesi del 2020, ad oggi, le vittime in Italia, sono 91 secondo le fonti Istat. Un anno che ha visto in crescita la violenza sulle donne a livello mondiale, ma in diminuzione il numero delle denunce, a causa delle misure di restrizione per motivi sanitari collegati alla pandemia e della riduzione della vita sociale. L’attività lavorativa e la scuola in situazioni di violenza domestica, normalmente, sono luoghi sicuri dove poter chiedere aiuto portando i propri segnali di violenza subita. Oggi, però, la forte riduzione dei contatti sociali e di compresenza obbligata può compromettere questa possibilità per le vittime. In considerazione di tale circostanza, da più parti sono state sollecitate misure idonee a supportare in particolare donne e minori. Il lockdown e i successivi provvedimenti hanno reso le donne più esposte alle violenze domestiche e nello stesso tempo la limitazione della libertà di spostamento ha reso difficile la denuncia delle violenze subite nonostante siano stati istituiti numeri appositi quale il 1522.
Nell’ottobre di quest’anno il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha bocciato nuovamente l’Italia, responsabile di ostacolare l’accesso alla giustizia alle donne vittime di violenza. Per questo resterà sotto vigilanza rafforzata e dovrà fornire, entro il 31 marzo del 2021, le informazioni sulle misure adottate per garantire un’adeguata ed efficace valutazione del rischio che corrono le donne che denunciano violenza e dimostrare la concreta applicazione delle leggi. L’Italia è stata anche sollecitata a fare di più per la prevenzione della violenza e per garantire la presenza dei Centri antiviolenza e delle risorse a loro disposizione e questo, nonostante poco più di un anno fa sia entrato in vigore il c.d. Codice Rosso ovvero della L. 69/2019.
L’entrata in vigore del Codice Rosso ha segnato una importante svolta per la tutela delle donne vittime di violenza prevedendo una sorta di corsia preferenziale per questi tipi di reato. Non appena gli organi di polizia o pubblica sicurezza raccolgono la notizia di un caso di violenza domestica di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di violenza sessuale o di stalking, si attiva una sorta di “bollino di precedenza”. Da un punto di vista procedurale sono stati ampliati da 6 mesi ad un anno i termini per consentire alle vittime di sporgere la denuncia, sono state aggravate le pene che sono aumentate se la violenza è avvenuta davanti ad un minore, a un disabile, a una donna incinta ovvero se la l’aggressione è armata. Pene più severe anche per i reati di stalking-
Sono stati introdotti nuovi reati come la deformazione dell’aspetto della vittima (pensiamo alle aggressioni con acido) o il reato di “revenge porn” per difendere più possibile le vittime di atti di cyberbullismo successivi ad una rottura sentimentale.
Ad un anno dalla entrata in vigore della normativa sono emerse alcune criticità dovute in parte alla previsione che impone di sentire la vittima entro 3 giorni (a volte rischiando di aggiungere pressione a donne già estremamente fragili) dall’altra dalla molteplicità di denunce che sono arrivate nei primi mesi dopo l’entrata in vigore della legge. La quantità di denunce richiede una maggiore competenza e specializzazione dei pubblici ministeri e delle forze dell’ordine al fine di rendere veramente efficaci gli strumenti che la normativa ha introdotto. Solo in questo modo riusciremo effettivamente ad avere una diminuzione dei femminicidi.
-La magistratura italiana, è portatrice di pregiudizio, per quanto riguarda i casi di violenza sulle donne?
Alla competenza degli organi preposti deve essere affiancato un forte lavoro di preparazione per abbattere i pregiudizi che ancora troppo spesso accompagnano questo tipo di denunce. La violenza sulle donne è purtroppo figlia di una cultura maschilista e patriarcale che va sconfitta in ambito sociale prima che giudiziario.
Quando leggiamo di episodi di femminicidio troppo spesso emerge una differenza nel riportare le notizie laddove parlando dell’uomo di usano termini positivi “lavoratore instancabile”, “padre premuroso” mentre parlando della donna spesso si scrive “lei lo aveva lasciato, voleva il divorzio; lui le aveva chiesto un’altra possibilità ma lei aveva detto no”, con una connotazione che sebbene involontaria, tende a perpetuare il messaggio di una società prettamente patriarcale.
Anche in sede giudiziaria sia civile che penale spesso all’atteggiamento dell’uomo viene associata una connotazione di minor disvalore utilizzando frasi e attenuanti quali “raptus”, “lite familiare”, “gelosia” si ritiene il colpevole quale a sua volta vittima di un impulso incontrollato, di una perdita momentanea di coscienza ecc.
Uno dei casi che più recentemente ha fatto scalpore è la decisione della Corte d’Assise d’appello di Bologna che, nel novembre 2018, ha riconosciuto le attenuanti generiche all’imputato condannato per l’omicidio della sua fidanzata, motivando in questo modo: “Sebbene quel sentimento [la gelosia, N.d.A.] fosse certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell’imputato, tuttavia esso determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come ‘una soverchiante tempesta emotiva e passionale’, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio: si tratta di una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità penale”.
Recentemente tali pregiudizi sono emersi nel caso dell’imprenditore milanese che organizzava festini a base di droga e alcool commettendo pesanti violenze su alcune ragazze.
Negli articoli, nei commenti, sui social si punta il dito contro le ragazze ritenute colpevoli di avere esito troppo il loro corpo, di essere andate volontariamente a tali feste ben sapendo che nelle stesse ci sarebbero stati droga e alcool. Come se questo fosse una attenuante per il “mostro” e non una circostanza totalmente neutra. Nessuno deve pensare di poter avere il diritto di compiere violenza su una donna che la stessa sia più o meno vestita, drogata o ubriaca. Fino a che questo concetto non sarà fortemente radicato nella nostra cultura, sarà sempre più difficile ridurre certi tragici episodi. La strada da percorrere per ridurre i “femminicidi” è molto lunga e passa, per prima cosa, dalla cultura sociale”.