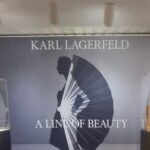La città “For All”: accessibilità, inclusione e interazione senza barriere
Per vivere senza barriere- di Maria Gabriella Alfano-
Alcuni anni fa, passeggiando lungo il Tamigi nella zona del Tower Bridge, entrai nella City hall, un edificio a forma di sfera, completamente vetrato, progettato dal celebre architetto Norman Foster. Gli undici piani dell’edificio ospitano il governo della città di Londra e gli uffici comunali.
 Al di là della qualità estetica, ciò che maggiormente mi sorprese fu l’assenza di scale. Una rampa elicoidale che si sviluppava a spirale lungo il perimetro interno della costruzione e dava accesso ai vari piani.
Al di là della qualità estetica, ciò che maggiormente mi sorprese fu l’assenza di scale. Una rampa elicoidale che si sviluppava a spirale lungo il perimetro interno della costruzione e dava accesso ai vari piani.
Di edifici privi di barriere verticali come quello di Londra ne ho visitati altri tra cui, in Europa, il Reichstag, sede del Parlamento di Berlino, anch’esso di Foster, il Museu d’Art Contemporani di Barcellona, progettato da Richard Meier e la Neue Staatsgalerie a Stoccarda di James Stirling.
 Edifici privi di barriere architettoniche, progettati per essere accessibili al maggior numero di persone possibile nella consapevolezza che la qualità dell’ambiente è determinante per quella della nostra vita.
Edifici privi di barriere architettoniche, progettati per essere accessibili al maggior numero di persone possibile nella consapevolezza che la qualità dell’ambiente è determinante per quella della nostra vita.
Non mi riferisco solo a chi è sulla sedia a rotelle perché disabile, ma anche ai genitori che portano loro bambini nei passeggini, ai viaggiatori con i trolley, agli anziani con o senza bastone, a chi è temporaneamente invalido perché si è fratturato un arto. Aggiungiamo poi le altre disabilità sensoriali (ciechi e sordi) o cognitive.
 Alcuni sono convinti che i disabili siano pochi. In realtà ce ne sono tanti, ma il più delle volte le barriere sono tali e tante da indurli a rinunciare a uscire di casa. Tanto per fare un esempio, chi ha barriere fisiche, prima di spostarsi deve verificare che il percorso sia sufficientemente largo per la carrozzina, che non vi siano gradini, buche o avvallamenti del piano stradale, che le rampe siano larghe e della giusta pendenza, e così via. Se anche uno solo di questi elementi viene meno, l’intero percorso diventa inaccessibile. Per non parlare dell’accessibilità sensoriale che necessita di dispositivi che orientino il cieco o il sordo.
Alcuni sono convinti che i disabili siano pochi. In realtà ce ne sono tanti, ma il più delle volte le barriere sono tali e tante da indurli a rinunciare a uscire di casa. Tanto per fare un esempio, chi ha barriere fisiche, prima di spostarsi deve verificare che il percorso sia sufficientemente largo per la carrozzina, che non vi siano gradini, buche o avvallamenti del piano stradale, che le rampe siano larghe e della giusta pendenza, e così via. Se anche uno solo di questi elementi viene meno, l’intero percorso diventa inaccessibile. Per non parlare dell’accessibilità sensoriale che necessita di dispositivi che orientino il cieco o il sordo.
Il tema del superamento delle barriere architettoniche fu affrontato per la prima volta negli Stati Uniti. Erano gli Anni Cinquanta quando nacque il movimento “barrier free” che dava voce alle tante persone colpite dalla poliomielite. Qualche anno dopo il movimento moltiplicò le sue attività per sensibilizzare l’opinione pubblica verso le esigenze dei tanti ragazzi che erano tornati dalla guerra in Vietnam con mobilità nulla o ridotta.
In Italia si cominciò a parlare di barriere architettoniche nel 1965 nel corso di una conferenza internazionale, organizzata a Stresa dall’ANMIL, l’Associazione nazionale dei mutilati e Invalidi del lavoro e dall’AIA, Associazione per l’assistenza agli spastici. A Stresa furono evidenziate le difficoltà che incontravano i disabili che provavano a partecipare alla vita sociale: ostacoli fisici presenti nelle città, negli edifici, nei mezzi di trasporto, ecc., vere e proprie barriere architettoniche.
Come accade in molti casi, l’importante movimento culturale crebbe negli anni e portò nel 1971 all’approvazione della legge 118 a favore dei mutilati e degli invalidi civili.
Il quadro legislativo si ampliò con il passare degli anni con norme riferite questa volta alla fruibilità degli spazi, fino alla legge 13 del 1989 ed ai vari decreti attuativi. Leggi e regolamenti da applicare non solo nell’edilizia pubblica, ma anche in quella privata, che sono stati arricchiti e perfezionati nel corso degli anni.
Ma al di là delle norme, proprio guardando ai numerosi fenomeni di disagio e di aggressività di cui sono piene le cronache, è cresciuta la necessità di rendere sempre migliore la qualità della vita nelle città in cui vivono persone delle più diverse età, condizioni, etnie, culture. Non solo, quindi, le categorie “deboli” dei disabili motori, sensoriali, ma anche altri soggetti, tra cui gli anziani, in costante aumento per l’invecchiamento della popolazione.
Gli edifici, gli spazi pubblici, i mezzi di trasporto, l’arredo urbano devono saper rispondere ai bisogni di tutti questi individui o almeno del maggior numero possibile di essi. Occorre, quindi progettare città “per tutti” e che termini come accessibilità, inclusione, interazione siano le parole d’ordine per garantire una vita senza barriere.